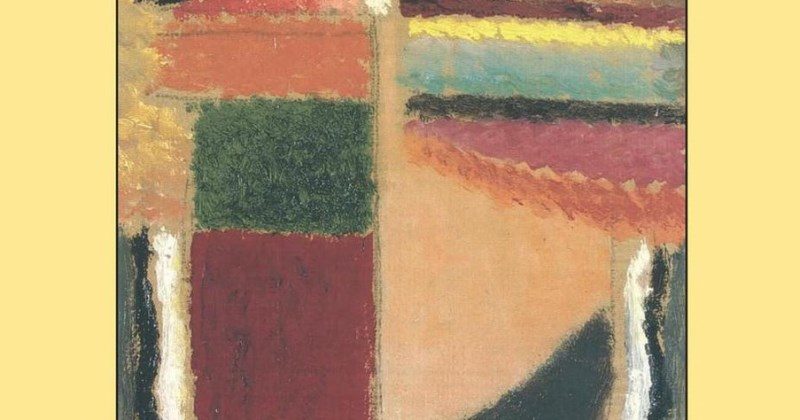“Profeti” della software culture: una letteratura profetica e multimediale
Su Agata Piromallo Gambardella, “Profeti” della software culture: Joyce, Rilke, Calvino (Milano, Franco Angeli, 2013)
Il testo si apre richiamando le parole di Lev Manovich, che descrive il software come la nostra interfaccia con il mondo, in grado di cambiare l’identità di ogni cosa di cui è composta una cultura. Ma è davvero così? Siamo certi del fatto che la nostra software culture rappresenti un’innovazione a tutto tondo? Agata Piromallo Gambardella non è convinta, perché alcuni concetti-chiave con i quali oggi dobbiamo confrontarci (disintegrazione della scrittura, sconfinamento dello spazio nel tempo e viceversa, dominio del virtuale) sono già presenti nella storia della cultura (dalla scienza alla filosofia, dallo sperimentalismo delle arti alla trionfale avanzata delle tecnologie) e soprattutto in alcuni momenti alti della esperienza letteraria novecentesca. Una riflessione che, nello specifico, attraversa tre opere di altrettanti scrittori rinomati: Ulisse di James Joyce, Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke e Le città invisibili di Italo Calvino.
Piromallo Gambardella si sofferma in primis sull’autore irlandese: il suo principale lavoro (uscito nel 1922) segna un punto di rottura epocale rispetto alla precedente tradizione letteraria. Leopold Bloom e la sua piccola odissea di un solo giorno per le strade di Dublino, infatti, offrono al lettore molteplici novità: il linguaggio mescolato a suoni che sprofonda nelle pieghe dell’inconscio, portandosi agli estremi limiti del dicibile, sempre sul punto di uscire dai confini della pagina per approdare in quelli meno rigidi di un palcoscenico; la rottura del discorso lineare, sostituito da un vertiginoso zig-zag espressivo che spazia tra gli interrogativi del ricordo e i sussulti di una pulsante corporeità (come nel monologo finale di Molly), oppure si apre a ventaglio su una dimensione corale in cui i personaggi si cercano, si incontrano e si scontrano, si violentano (basti pensare al capitolo Circe ovvero Il Bordello); una commistione di lingue diverse, capace di creare assonanze e dissonanze funzionali alle varie finalità espressive (l’incontro/scontro tra Stephen Dedalus e Bloom, tra l’antico irlandese e l’antico ebraico).
Grazie a queste caratteristiche, l’Ulisse favorisce la lettura come processo di immersione totale nel testo, in un andirivieni di sensazioni inesprimibili, sull’onda di una musicalità ricca di significati che non si lasciano mai afferrare del tutto. È quanto accade oggi con i social network, nei quali non è preminente la comprensione puntuale delle singole parole, ma il loro carattere evocativo, la loro sonorità intrinseca che avvolge il lettore-ascoltatore, lo irretisce per renderlo compartecipe di quella avventura chiamata comunicazione. In essi troviamo il rimando continuo al gioco delle onomatopee, le emozioni ancora in cerca di un alfabeto, le parole utilizzate come suoni, il discorso corale che accompagna i gesti quotidiani dei parlanti con un ritmo che è sempre lo stesso da secoli. Ecco perché il nomadismo espressivo dei social network si fonde con la pulsione di erranza e la frantumazione del linguaggio tipiche dell’Ulisse. Da uno dei più importanti romanzi del ‘900 a una pietra miliare della poesia del medesimo periodo, il passo è breve, e ci conduce alle Elegie duinesi (prima edizione pubblicata nel 1923) di Rilke.
In questa raccolta lirica, lo scrittore, poeta e drammaturgo austriaco di origine boema mette in risalto la relazione tra l’uomo e l’Angelo, tra le dimensioni del visibile e dell’invisibile, dove la tensione vive una costante oscillazione in cui l’Angelo (che ha nostalgia del mondo umano, si stupisce di quanto felice possa essere una cosa terrena, di come le cose possano credere in noi, i più passanti di tutto il Creato) è sempre sul punto di rischiare di essere “sedotto” dall’uomo, mentre questi si proietta nell’invisibile tramite le cose trasfigurate dalla sua parola. Da un lato, dunque, l’Angelo è muto perché non deve rendere eterne le cose; dall’altro, invece, l’uomo, con il suo dire, “salva” le cose: quando esse sono oggettivate, visibili, il dissolvimento le minaccia, ma dal momento in cui l’uomo le accoglie nel suo invisibile cuore, allora sono destinate a durare. Sfruttando tale capacità, l’essere umano può entrare in un rapporto di scambio con l’Angelo. Diventano, così, necessari l’uno all’altro: l’uomo ha bisogno dell’Angelo, ma pure l’Angelo ha bisogno dell’uomo per realizzare quella intelligenza collettiva teorizzata da Lévy che si sviluppa nell’ambiente immateriale della rete (tra il teologico e il tecnologico), che solleva le intelligenze individuali verso una dimensione cognitiva più ampia e profonda, che conduce l’uomo dal visibile all’invisibile della conoscenza, perché la conoscenza è sempre una lenta marcia verso l’invisibile.
Del resto, già all’inizio del secolo scorso, un vecchio medium quale il cinema aveva posto il problema del rapporto tra visibile e invisibile. In che modo? Tramite quella che Gilles Deleuze definisce immagine-tempo, un’immagine che non vuole rappresentare esclusivamente l’azione ma anche il tempo (cioè l’invisibile), quel tempo chiamato in ogni istante a sdoppiarsi nelle due direzioni eterogenee del passato e del futuro. È il caso, per esempio, dei film Il Cielo sopra Berlino e Così lontano, così vicino, entrambi del regista tedesco Wim Wenders, i cui Angeli hanno toccato la terra, hanno accettato il rischio di immergersi nella transitorietà dell’umano e di condividerne il destino. Da Rilke a Wenders, dall’uomo che aspira alla dimensione angelica (dove la vita e la morte confluiscono in un unicum indistinto) fino all’Angelo che si mostra creatura aperta al rischio della vita terrena, il cerchio si è (quasi) chiuso.
All’appello manca ancora Calvino, che in alcune sue opere parla di rapidità e leggerezza, anticipando in questo modo il salto verso la dimensione dell’invisibile favorito dalla crescente digitalizzazione del mondo, dalla sua crescente smaterializzazione dovuta allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione. È il caso del romanzo Le città invisibili (1972), nel quale lo scrittore italiano (ma nato a Cuba) immagina che Marco Polo, inviato dal Gran Khan dei Tartari nei suoi immensi territori per fargliene un resoconto minuzioso, si trovi a descrivere le città che incontra nelle sue spedizioni: città stupefacenti, irreali, che crescono, spariscono e rivivono come in un gioco di specchi nel quale la tensione tra situazioni diverse non si risolve mai; città invisibili sottratte a ogni logica spazio-temporale, capaci cioè di andare oltre il senso del luogo (à la Meyrowitz) e del tempo (ai concetti di sviluppo, evoluzione si sostituisce quello di un continuo ritorno al medesimo punto di partenza).
Tutto sembra essersi condensato in un gioco, anzi in un videogioco, con le città che smettono di essere luoghi dove si svolge una narrazione, per diventare esse stesse narrazioni infinite. Proprio come le nostre città, che oggi viviamo attraverso le fotografie scattate, le immagini pubblicitarie e le scritte al neon, camminando senza tregua per le strade (ormai semplici nastri di scorrimento) in veste di cybernauti il cui peregrinare non conosce limiti.
Ricapitolando, Piromallo Gambardella parte da Joyce – e dalla scrittura che si ibrida con l’oralità – per arrivare ai social network, a un tipo di scrittura (mobile e interattiva) che mescola il visibile con l’invisibile e permette a tutti di parlare, interagire, vivere la loro quotidianità sui milioni di schermi dove le parole si inseguono e si sovrappongono, cercando di riprodurre il loro suono. Infine, l’autrice giunge al videogame, all’incontro tra parola scritta e immagine in movimento che dà luogo a nuovi generi narrativi e le consente di chiudere il cerchio. Con una consapevolezza: tutte le realtà e le fantasie possono prendere forma soltanto per mezzo della scrittura.