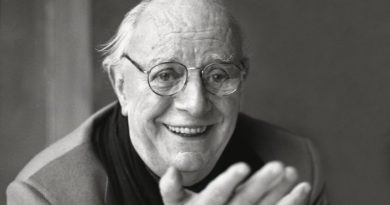Lettera aperta a Fabrizio De André
Caro Maestro Faber,
da quando te ne sei andato, la gente continua a morire per mano di malattie simili a quella che ti ha portato via. Da quando te ne sei andato, hanno continuato a rimproverare all’anarchia di essere pericolosa, addebitandole manifestazioni che non sono le sue, relegandola alle cronache mediocri dei giornali e delle televisioni, chiudendola ancora di più in quel silenzio che così male la descrive e così male la presta ai balordi chiacchiericci e agli strepitii sconsiderati di chi non le vuole bene.
Tu dei dialetti hai detto che sarebbe necessario parlarli, che non andrebbero smarriti, che sono fondamentali per nutrire le lingue nazionali e che anche il gusto di parlarli aiuta la resistenza all’invasione di idiomi buoni solo “per commerciare patate e baccalà”. Invece più passa il tempo e meno si ha il coraggio di ammettere che la lingua dialettale non è una diminuzione di grado del proprio livello d’istruzione, ancor meno che serva a qualcosa rinunciarvi soltanto in onore di una lingua più lontana. A furia di vergognarsi di ipotetiche tentazioni, s’è perduto pure quello che avrebbe potuto fare da magra consolazione, a dispetto del fatto che un dialetto è pure la misura di una lingua che custodisce un genere di intimità. Molti, troppi pensano che andare avanti sia l’insulto al dietro.
Maestro Faber, hai parlato male dei giudici. Avevi ragione, continuano a fare ingiustizia e a fare politica, e non per il bene della politica. Tu del giudizio te ne intendi, perché l’hai sottratto alla tentazione di ostentarlo pubblicamente, riservando pubblico perdono ai tuoi rapitori, sorvolando senza patetismi pure sulle accuse di chi sosteneva che tu appartenessi a chissà quali organizzazioni criminali. E non credere che oggi sia cambiato qualcosa, se non l’aumento dello sconforto davanti al fatto che il giudizio prende sempre il sopravvento, quando invece andrebbe sospeso.
Caro maestro, di te dicono quasi sempre le stesse cose. Ti hanno rinchiuso in un formato da far circolare come un manifesto di retorica. Quante volte mi è successo di pensare che forse ne avresti a male. Hai scritto e cantato delle prostitute e dei drogati, e di tutto quanto rientrasse nella folla sterminata popolata da reietti e diseredati, senza mai accomunare le singole disgrazie, senza mescolare le tragedie private, ma raccogliendole in un’aneddotica di faccende vicine e lontane, passate e future, senza la mano maldestra della maldicenza, della cattiva propaganda, o della semplice confusione. Oggi, purtroppo, accade sempre di più il contrario, in un’assegnazione generale di ruoli e di appartenenze che sembrano una grande commedia moderna.
Hai detto che non bisogna considerare sbagliati i valori dei giovani, perché forse questi sono soltanto diversi da quelli degli adulti. Forse mi sbaglierò io, ma più che alla metamorfosi dei valori, mi capita più spesso di assistere all’incertezza se ce ne sia ancora qualcuno.
Ecco, vedi, quante cose giuste hai detto, e quante ne restano ancora da portarsi appresso. Tu hai detto giusto, ma il tempo ti ha voluto comunque dare torto. È l’eterno paradosso di chi è destinato ad avere ragione. Rientra nelle forme più nobili della contraddizioni, quelle che a te stavano tanto a cuore, quando dicevi che in fondo sono le cose che ci rendono uomini.
Alla fine, mi consola l’idea che non leggerai questa lettera immalinconita, perché non so come e dove spedirtela.