“Josefine e io”, di Enzensberger. I topi di Kafka diventano uomini
Esiste un legame sottile tra Josefine e io di Enzensberger e Josefine la cantante di Franz Kafka. Due racconti legati da un allungamento, in una soluzione di continuità che trasforma l’uno in interpretazione e adattamento dell’altro. Una sonata a quattro mani concordata dalla letteratura. Kafka, nel suo ultimo racconto, in un apologo illuminante e disperato, verbalizza la voce dei topi, cifrando sulla carta le profondità dell’esistenza, incise sui suoi nastri corrosi dai remoti fruscii della sua poetica profetica.
Hans Magnus Enzensberger recupera questi nastri e li ripulisce, arrangiandoli con voce umana, sulle labbra di un giovane economista e su quelle di una vecchia diva della musica lirica. Tra i due non sembra esserci alcun elemento comune. I loro insiemi restano distinti e separati per sempre, in una Germania post comunista, post muro di Berlino, post ogni cosa, retrattile ai rallenty filosofici del terzo millennio, riluttante, ormai, alla vita capace di sedersi a un tavolino, di prendere il tè e col tè tutta la serenità terapeutica di fare le cose con calma in questo tempo che, senza una ragione precisa, ha fatto dell’isteria una pratica ascetica universale.
Joachim, giovane economista dalle rosee prospettive, salva Josefine K. da uno scippo. Lei è una ex cantante lirica del periodo nazista, vecchia donna ancora pervasa da una verve che sa di nobiltà e di mistero. Due pedine di classe, lampadine accese nel buio, messe lì, immobili, a fissarsi, perché la loro mobilità sia fatta di pensiero e del pentimento inconfessabile dettato dall’orgoglio. Joachim e Josefine si incontrano ogni martedì pomeriggio, durando in provocazioni e conversazioni, mentre il mistero di Josefine li divora poco a poco, nello spazio confidenziale di una governante che calibra la sua misura di confidenza con Josefine, assuefatta al suo stesso carisma. Josefine e la sua governante sembrano quasi realizzare l’orizzonte parificante della caduta dei regimi. L’autorevolezza e l’utilità adesso corrono sullo stesso piano, per dare istruzioni al nuovo millennio e ai suoi anni iscritti sul registro dei circoli sociali e delle nostalgiche rimembranze.
del periodo nazista, vecchia donna ancora pervasa da una verve che sa di nobiltà e di mistero. Due pedine di classe, lampadine accese nel buio, messe lì, immobili, a fissarsi, perché la loro mobilità sia fatta di pensiero e del pentimento inconfessabile dettato dall’orgoglio. Joachim e Josefine si incontrano ogni martedì pomeriggio, durando in provocazioni e conversazioni, mentre il mistero di Josefine li divora poco a poco, nello spazio confidenziale di una governante che calibra la sua misura di confidenza con Josefine, assuefatta al suo stesso carisma. Josefine e la sua governante sembrano quasi realizzare l’orizzonte parificante della caduta dei regimi. L’autorevolezza e l’utilità adesso corrono sullo stesso piano, per dare istruzioni al nuovo millennio e ai suoi anni iscritti sul registro dei circoli sociali e delle nostalgiche rimembranze.
Enzensberger afferra con delicatezza due personaggi che sembrano provenire da mondi diversi. Una cantante lirica che guarda alla vita senza più voglia di cantare, come se avesse già cantato abbastanza una musica che non si fa più ascoltare, e un giovane economista tutto impegnato all’adattamento della vita nuova in cui usa gesti d’avventore, in una specie di supermercato dove la merce non è in vendita ma vi alberga, tra le partite di calcio in TV e la malsana spensieratezza di una giovinezza invecchiata all’ombra di storie attinte dall’immaginazione, e mai realmente vissute. Vive di riflesso questa nuova gioventù tedesca, e non soltanto tedesca, che si affaccia al progresso con fare spavaldo e anacronistico.
L’autore mette di fronte i due personaggi, in un sistema dialogico fatto di leve e carrucole dialettiche astute,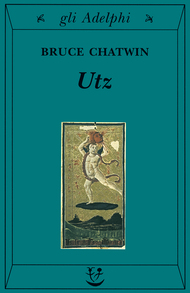 dapprima in un conflitto apparente e poi in uno stato di grazia emotiva che li fa confessare l’uno all’altro di essere venuti al mondo con le loro ossessioni e i loro segreti, e che la distanza non è così siderale come invece ordinerebbero le convenzioni generazionali.
dapprima in un conflitto apparente e poi in uno stato di grazia emotiva che li fa confessare l’uno all’altro di essere venuti al mondo con le loro ossessioni e i loro segreti, e che la distanza non è così siderale come invece ordinerebbero le convenzioni generazionali.
Il racconto di Enzensberger rievoca il retrogusto amaro e nostalgico dell’Utz di Bruce Chatwin, in cui le porcellane, oggetto protagonista del romanzo, si ergono a simbolismo sacrificale, dove Chatwin agisce per sottrazione, dove la perdita delle porcellane diventa smarrimento e umiliazione. In Josefine e io è il dialogo a farsi simbolo di processo individuale e collettivo, in cui sono le parole l’insidia tra due personaggi spersonalizzati nel loro tempo, ma in cieca esplorazione di un io comune che, con fare tragico e burlesco, volta loro le spalle. Il racconto di Enzensberger chiude il cerchio intorno a un lungo diametro, nella sua bibliografia regolata da una letteratura che sa di matematica emotiva.




