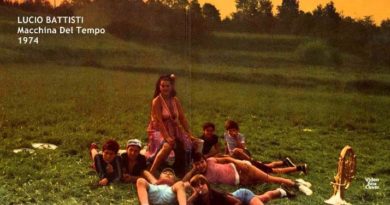Marcello
Pedalavo verso casa. Avevo finito il turno di notte da mezzora, pedalavo e sudavo, era un maggio molto caldo, il telegiornale diceva che era il maggio più caldo degli ultimi centocinquantanni. Guidavo quel ferro vecchio da un anno, da quando l’auto mi aveva lasciato. Lasciato non è vero, il meccanico aveva detto che per rimetterla a posto ci sarebbero voluti cinquecento euro. Gli avevo detto che da lì a qualche giorno gliela avrei lasciata e così feci. Ancora non ero stato in grado di andarla a ritirare. Non rispondevo più alle sollecitazioni telefoniche ormai da sei mesi. Arrivai a casa stravolto, ma niente in confronto alla cucina, alla camera da letto, al bagno. Mi decisi a mettere un po’ d’ordine. Aprii le finestre e mi diedi da fare. Essendo piccola, in un paio d’ore riuscii a darle un aspetto presentabile. A toglierle l’odore di stantio. Presi un sacchetto nero e infilai una serie di carte che erano sulla scrivania da troppo tempo. Bollette scadute, sollecito del condominio, liste per spese mai fatte e cose così. In più trovai il biglietto di Loredana che mi aveva scritto lo stesso giorno in cui la macchina non volle saperne di partire:
“Marcello caro, ti scrivo perché non riesco a parlarti di persona, sono inetta, me lo dici spesso. Non riesco più ad andare avanti. Sono stati gli anni peggiori della mia vita quelli con te. Anni di rinunce, anni di frustrazioni. Ti ho sempre detto che al mio fianco avrei voluto un uomo sul quale contare, invece sei sempre stato tu a dover poggiarti su di me. Non parlo solo economicamente, sei infantile, sei insicuro, hai bisogno di una psicologa non di una compagna. Abbi cura di te”.
Piegai il foglio una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Poi lentamente iniziai a strapparlo fino a farne coriandoli. Non provai mai a chiamarla. Non feci nulla per provare a sistemare la situazione con lei. Aveva ragione e non avrei potuto dirle niente. Non soffrii neanche, era finita da tempo. L’unica reazione che ebbi fu quella di non dare più acqua alla sua pianta grassa. La sistemai sul tavolino di fronte al divano e la sera mi sedevo lì e la osservavo. Osservavo il terreno essere sempre più grigio. Loredana amava molto quella pianta, l’aveva chiamata Michela (le piaceva dare i nomi alle cose). Una sera la trovai sgonfia da un lato. Non era più verde, era color prugna. Sorrisi compiaciuto.
Infilai i coriandoli nel sacchetto che annodai. Quando suonò il campanello di casa sapevo già chi mi aspettava fuori dalla porta.
Saro non era molto alto, faceva il broker finanziario ed era il mio vicino di casa. Era sempre molto agitato, muoveva le mani in continuazione. Nonostante lavorasse in casa era sempre vestito come da cerimonia. Mi interessava poco sapere perché.
“Marcellino, vuoi farmi il piacere di mangiare?, dai, ti cadono i pantaloni” esordì senza ancora aver messo piede in casa.
“Caffè?” chiesi.
“Certo, sono qui per questo” sorrise.
Preparai il caffè.
“Se tu avessi qualche risparmio ti farei guadagnare in breve tempo abbastanza da comprarti un’auto nuova”.
“Metti lo zucchero”.
“Hai quasi quarant’anni, lavori lì da quanto? dieci anni?, e ti puoi permettere una bicicletta, che poi quella tra un poco ti si aprirà in due”.
“Non hai caldo con la giacca?”, domandai asciugandomi il sudore con un tovagliolo di carta.
Saro girava lo zucchero nella tazzina con una lentezza che mi esasperava. Mi resi conto che sudavo anche per la stanchezza.
Ancora non avevo tolto le scarpe e mi facevano male i piedi. Il mio vicino di casa beveva il caffè e mi raccontava che stava pensando di sposarsi con Giulia. Voleva avere dei figli. Facevo fatica a sentirlo, il sudore mi bagnava il collo.
Saro andò via, io bevvi un sorso direttamente dalla moka. Sfilai le scarpe e i calzini. Avevo bisogno di una doccia, avevo bisogno di dormire. Seduto su una sedia in cucina, guardavo fuori dalla finestra senza riuscire a fare niente. Non riuscivo a muovermi. Chiusi gli occhi. Il gomito sul tavolo e la faccia appoggiata alla mano. Squillò il telefono. Era mio padre, mi chiese di andare da lui, era urgente, non poteva aspettare. Infilai i calzini e poi di nuovo le scarpe. Saltai sulla bicicletta e mi trovai non so come nel salotto di casa dei miei. C’erano anche Anna e Francesca, le mie sorelle.
Anna portò da bere un’orzata. Francesca era la più grande, io il mediano e Anna la piccola che da quando mamma era morta aveva preso le redini di casa, diventando, di fatto, la badante del vecchio.
La maglietta era diventata una seconda pelle. Il ventilatore acceso non riusciva a far altro che rumore.
Papà ci disse che la chemio non stava dando i risultati che i medici speravano e che nessuno poteva dire quanto tempo gli restava, magari qualche anno, magari qualche mese.
Semplicemente mise al corrente me e Francesca che la casa sarebbe rimasta a Anna e che gli unici soldi che aveva sarebbero serviti per il suo funerale. Erano le quattordici e tredici e la mia orzata era diventata un tè.
Non ci dicemmo molto altro.
Quando uscimmo, Francesca mi chiese di fermarmi un attimo con lei che voleva parlare. Ci sedemmo su una panchina all’ombra di un grosso albero nel parco di fronte casa.
“Non dici nulla?, cioè perché non si divide in tre come buona norma vuole? Perché deve tenersela Anna?”.
“Perché gli è rimasta a fianco e noi no, credo sia giusto” dissi.
“Ma a me avrebbe fatto comodo avere un po’ di liquidità, vendere la casa e…”.
“…”
“A te no? Non abbiamo mai avuto niente da mamma e papà, mai. Non avevano i soldi per loro, figuriamoci per noi e ora che poteva un minimo aiutarci che fa? Aiuta solo uno dei tre, ti pare normale?”
Pedalai verso casa. Una volta sul pianerottolo trovai Saro seduto sulle scale di fronte alla porta di casa sua aperta. Piangeva.
“È morto Olmo” singhiozzò.
“Olmo?”
“Sì, il mio coinquilino ai tempi dell’università”.
Gli dissi che mi dispiaceva, mi sedetti di fianco a lui e rimasi lì in silenzio sino a quando non smise di piangere.