Sogniloqui, i monologhi dell’inconscio
L’antologia di Stefano Taccone, Sogniloqui (Iod edizioni, Napoli 2018), può essere presentata ai lettori usando un bisticcio di parole come una doppia singolarità. Da una parte c’è il suo carattere di diario onirico, le cui linee-guida sono sfuggenti alle regole della narrativa convenzionale, dall’altra il trattarsi di uno sconfinamento letterario a opera di un saggista, docente e critico d’arte, figura quindi abituata a usare gli strumenti dell’analisi per decriptare le visioni altrui, piuttosto che crearne di proprie. 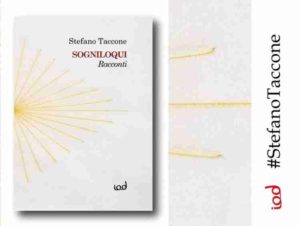
Il tema del sogno, o meglio, il suo habitat che fa da sfondo ai dodici racconti della raccolta, è stato territorio di elezione del primo surrealismo che si è rifatto al suo linguaggio libero da schemi e dalle zavorre della logica, per sperimentare stati di coscienza sospesa e nuove forme espressive. In questa accezione di luogo altro, in accordo alla lettura di Aldous Huxley nel suo saggio del ‘56 Paradiso e inferno, l’ambiente onirico fa da ponte tra la parte diurna del critico Stefano Taccone e il suo io sognatore, offrendo una tabula rasa priva di strutture precostituite in cui l’evento assurdo in oggetto diventa l’asse portante di una narrazione stupefatta e spesso caustica, genuinamente restituita coi suoi salti temporali e improvvise incongruenze tipiche dello stato sognante, che la rendono non catalogabile nei codici delle nostre forme narrative.
Per intenderci meglio bisogna ragionare per antitesi con l’elemento propulsivo di ogni storia, mito o narrazione ossia il conflitto, motore di eventi che si susseguono per andare incontro a una risoluzione e una fine. Un processo che potremmo figurare con un moto centripeto, che porti la vicenda ad addensarsi sempre più raggiungendo il suo nucleo drammatico.
Nel caso del sogno, invece, abbiamo una narrazione centrifuga, dispersiva, che va allontanandosi da un asse definito per muoversi con disinvoltura in associazioni di idee, contiguità di significati, metafore visive o esasperazioni, tutti elementi che si susseguono in modo da trovare un senso per sottrazione. Padri nobili di queste operazioni, oltre il già citato surrealismo e la scrittura automatica dei vari Desnos, Soupault, Breton, sono autori come Landolfi con i suoi simbolismi, le realtà magiche di Buzzati, le geometriche costruzioni di Calvino. Ed è appunto al grande scrittore de Le città invisibili e Palomar che si richiama la visionarietà ossessiva del primo racconto, Tagliatelle millimetrate, un inquietante parossismo quasi kafkiano, imperniato su una sequenza di strisce di pasta dalle misure rigorosamente esatte, da consumare secondo un ordine precostituito. Alla logica autoreferenziale di questo racconto ne seguono altri più assurdi come Spirale caprina in cui la messa in scena di un improbabile (ma non troppo) vernissage dà modo all’autore di fare una sottile ironia sul mondo dell’arte contemporanea.
 I riferimenti al mondo artistico sono una costante che si affaccia spesso nei vari sogniloqui, sotto forma di citazioni di protagonisti antichi e moderni, quasi a tradire la matrice culturale dell’autore inevitabilmente coinvolta nell’orchestrazione delle avventure oniriche, ma altrettanto lo è l’ombra ingombrante di Napoli che è presenza fissa dell’immaginario di Taccone, coinvolto come tutti i suoi conterranei dai ritmi e le follie della grande città campana. Lo possiamo vedere in Girella cumana, in cui l’irruzione di un treno metropolitano nel cielo dell’io narrante lo porta a riflessioni che collegano insieme installazioni artistiche, ricordi d’infanzia e nevrosi di pendolare.
I riferimenti al mondo artistico sono una costante che si affaccia spesso nei vari sogniloqui, sotto forma di citazioni di protagonisti antichi e moderni, quasi a tradire la matrice culturale dell’autore inevitabilmente coinvolta nell’orchestrazione delle avventure oniriche, ma altrettanto lo è l’ombra ingombrante di Napoli che è presenza fissa dell’immaginario di Taccone, coinvolto come tutti i suoi conterranei dai ritmi e le follie della grande città campana. Lo possiamo vedere in Girella cumana, in cui l’irruzione di un treno metropolitano nel cielo dell’io narrante lo porta a riflessioni che collegano insieme installazioni artistiche, ricordi d’infanzia e nevrosi di pendolare.
Il processo di produzione dei racconti è quello di un reportage in presa diretta, che affida alla memoria diurna il compito di fissare su carta ciò che resta di un sogno e quindi ne indaga i simbolismi e le sciarade che rivolge a se stesso attraverso gli slittamenti di significato delle sue rappresentazioni. C’è un delicato equilibrio tra la poesia che scaturisce dalla leggerezza di queste brevi immagini-farfalla, unita allo sguardo critico dell’autore con cui reinventa il dato reale per indicarne l’invadenza, come avviene ne La rete negli occhi, apologo cyberpunk in cui il web con cui flirtiamo abitualmente molte ore al giorno si salda alla nostra retina comparendo nel campo visivo con la sua stringa di navigazione, in un matrimonio indissolubile di corpo, pixel e dati. Su un piano altrettanto sociologico rivolto stavolta alla vita notturna della popolazione giovanile, in Ragazza spugna assistiamo alla metamorfosi di una giovane praticante della movida e dei suoi rituali, esemplificata in un unità assorbente di alcoolici fino a diventare sotto lo sguardo indifferente di tutti una grottesca maschera alla Sponge Bob. Un allegoria trasparente che grazie all’approccio candido e meravigliato della scrittura sfugge ai rischi del sermone moralista mantenendosi scetticamente a distanza.
Tra le varie derive dell’antologia, attenta al sociale e a temi forti come il razzismo, troviamo l’ossessione contemporanea verso il cibo, oggetto di consumo, venerazione e giudizio, così come l’ecologia che sottende la trama fantascientifica di Cacotopia flegrea, godibilissima parabola alla Ballard, in cui un processo darwiniano distorto e l’allagamento degli spazi abbandonati dello zoo portano gli animali a divorarsi tra loro dando vita a nuove razze mutanti. Un processo che segna l’inizio di una trasformazione con echi apocalittici su larga scala, asciugata da ogni spettacolarità hollywoodiana e restituita al ruolo di simbolo della nostra incuria dell’ambiente, pronto in ogni momento a reagire in maniera inaspettata.
C’è molta materia di riflessione nelle righe dei racconti di Sogniloqui, concentrata in un numero di pagine ridotto amplificato però dall’eco delle tante domande irrisolte che pone. Con una valigia piena di sonno lucido ci invita ad avventurarci al di là dello specchio delle nostre certezze. A volte ad occhi chiusi si vede meglio.




