Torino Film Festival giorno 4, lettera d’amore al cinema
Lasciando da parte i classici, in 35mm. (pochi) e in DCP, l’opera più interessante in cui ci siamo imbattuti nella giornata di ieri è lo sperimentale Ne croyez surtout pas que je hurle del francese Frank Beauvais, ospitato in quel polmone verde della manifestazione che è da sempre, a Torino, la sezione “Onde”, curata da Massimo Causo e Roberto Manassero. Soprattutto non pensiate che mi metta a urlare: è questa la traduzione più o meno letterale del titolo di quest’opera sorprendente che è un lungo monologo, di straordinario valore letterario, sul quale sono innestate una serie di immagini, lacerti brevi, brevissimi, fulminei, tratti da circa 400 film.
Nel giugno 2016, infatti, in seguito a un momento di forte depressione dopo la fine di una relazione amorosa con il suo compagno, Beauvais si ritirò in un piccolo villaggio dell’Alsazia, lontano da tutto e da tutti, senza contatti con il mondo esterno e senza auto, con la stazione più vicina posta a decine di km. di distanza. Il regista approfittò di questo periodo per gettarsi a capofitto nella lettura e soprattutto nella visione di film, guardandone 400 nel corso di sei mesi, attraverso DVD oppure scaricandoli in rete, alternando capolavori a opere meno note, reperite su alcuni siti specializzati.
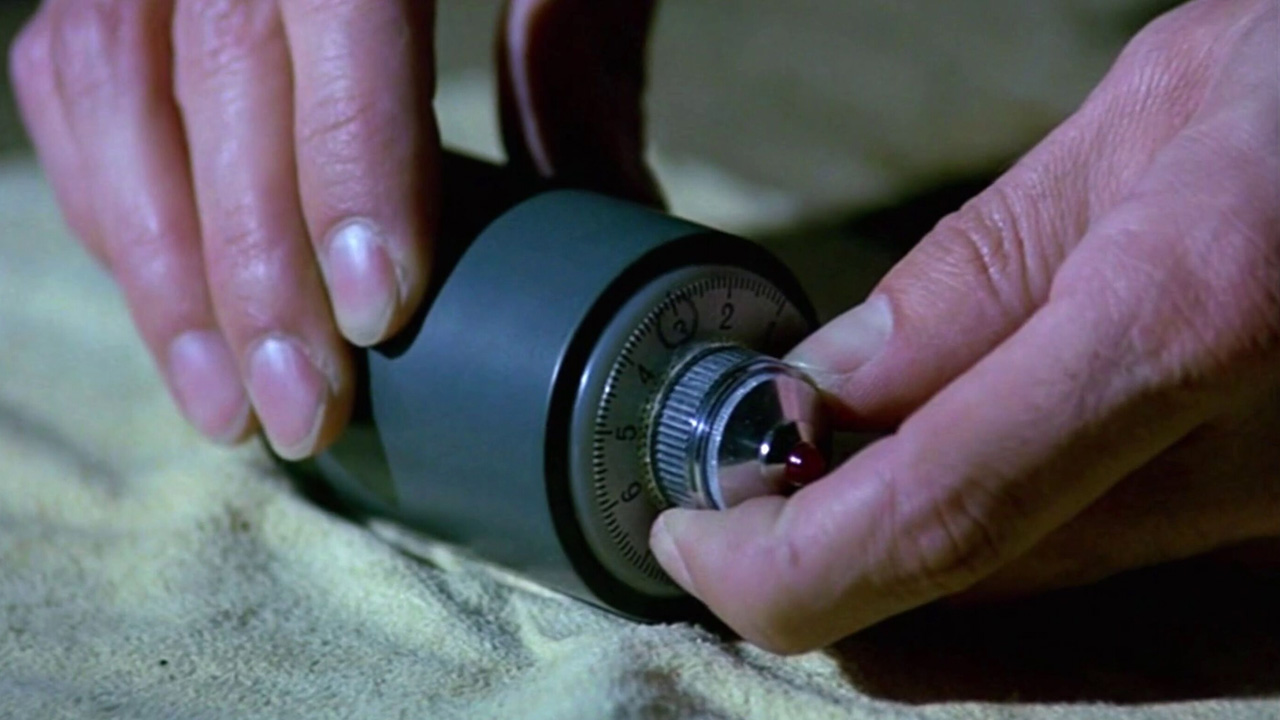
Il cinema come terapia del dolore, dunque, come arma a un tempo di distruzione di sé e di salvezza, di sublimazione del proprio io e di accettazione di se stessi, riparo sicuro da un mondo che ci riversa addosso continuamente le disgrazie umane e le catastrofi. Mentre l’autore si immerge totalmente nella “magnifica ossessione”, come se il cinema fosse un pianeta sconosciuto o mai del tutto esplorato, dalla Terra arrivano le notizie degli attentati terroristici di Istanbul e Nizza, del terremoto in Centro Italia, della morte di Prince, della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. L’uomo è impotente, schiacciato, sopraffatto da quella sorta di insostenibile pesantezza dell’essere, dal corso ineluttabile degli eventi. Il cinema diventa allora strumento di lotta ma anche di alienazione: bisogna scappare, buttarsi tra le braccia di Bergman, Pudovkin, Guiraudie, Truffaut, di tanti, tantissimi altri, contemplare ammirati questo tentativo, fatalmente destinato allo scacco, di rifare il mondo, che dura ormai da più di centoventi anni. E pensare che esso sia la vita.
Per circa 75 minuti, lo spettatore viene letteralmente sommerso da un diluvio di parole e immagini, in un monologo che sembra guardare alle lucide e febbrili elucubrazioni di Antoine Roquentin, l’antieroe de La nausea di Jean-Paul Sartre o ai ragionamenti del protagonista de La caduta, altra opera capitale nata dalla penna e dalla mente di Albert Camus.
Operazione intellettualmente poderosa, sorta di Histoire(s) du cinéma godardiana, altrettanto rigorosa ma più emotiva, Ne croyez surtout pas que je hurle, con il suo flusso inarrestabile, incontrollabile per quanto controllatissimo, corre però il rischio di scivolare presto nella bulimia e di provocare sazietà prima che l’ora e un quarto sia terminata, facendo sì che lo spettatore venga trasportato dentro un sogno del quale, una volta risvegliato, ricorda solo sparuti elementi, destinati anch’essi a essere troppo presto dimenticati. Resta tuttavia la consapevolezza, terribile e consolante, che di fronte a un mondo funestato da lutti e dolori, si può sempre tentare di scappare pronunciando la più sublime e innocua delle domande: “E se guardassimo un film?”. Solo per realizzare che siamo ancora vivi. Forse.
@RIPRODUZIONE RISERVATA – Ne è consentita esclusivamente una riproduzione parziale con citazione della fonte, Milena Edizioni o www.rivistamilena.it




