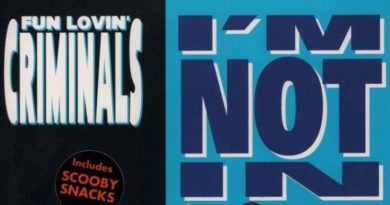Andare
di Eliana Petrizzi
Sorvolando in aereo il mondo, fiumi, regioni e città somigliano a piccole macchie di malattia. Si dissipano fibre, racconti e memorie. Il viaggiatore si svuota di tutto ciò che è bordo e appartenenza, per compararsi a ogni cosa. Una volta arrivati nel luogo prescelto, le scarpe del viaggiatore vanno senza rumore, in segno d’intimità e rispetto. I suoi abiti stringono un patto affettuoso con i colori del paesaggio, le braccia si fanno mansuete come gli arnesi usati dalla gente dei villaggi.
Il turista, al contrario, vuole stare comodo e mangiare pulito; ogni minimo imprevisto diventa l’occasione per chiedere rimborsi e risarcimenti. Il viaggiatore lascia correre e perdona; gli stanno bene i ritardi, le ruote bucate, le aspettative deluse e le imperfezioni, perché ha imparato che il brutto, più che un’obiezione alla bellezza della vita, è spesso il palo a cui tieni legato l’aquilone. Il turista guarda la gente di un Paese straniero come da dietro una vetrina. La paura dell’incontro lo convince alla distanza da ciò che ignora. Il viaggiatore, invece, vive con la gente; spesso resta in silenzio cercando di capire, in una doverosa revisione di se stesso.
Ho iniziato a viaggiare a diciotto anni, con tutta l’audacia che la giovinezza comandava. Da sola e senza programma, votata alla passione dell’imprevisto e al rischio delle contingenze, incurante dell’angoscia di mia madre, che per giorni non poteva ricevere mie notizie, persa com’ero in un deserto o in altri luoghi sperduti del pianeta. In questo modo, non in altri, ho potuto conoscere il mondo, incontrare popoli, sciogliermi nel loro calore. Sono grata perché ho viaggiato in tempi in cui era possibile per una donna andare da sola. In quegli stessi luoghi sarebbe oggi impossibile recarsi. Il mondo si è fatto piccolo a causa della globalizzazione e della crudele stupidità degli uomini. Anche meno interessante: troppo spesso, i riti e le tradizioni dei popoli diventano spettacoli recitati ad hoc per un manipolo di turisti paganti, nel circo da due soldi dell’antropologia da selfie.
Quando, per un motivo o per un altro, non posso partire, mi piace guardare in TV documentari di viaggio. Ma c’è una cosa che nessuna foto, video o documentario potranno mai sostituire: è l’abitudine allo stupore, vivere il tempo dimenticando l’ora e il giorno; è meravigliarsi di ogni cosa e persona, in una ritrovata appartenenza alla grande anima del mondo. Io aspetto ancora nuovi luoghi per lo stupore che, ho imparato, sono a volte molto più prossimi di quanto non si creda. Ci sono partenze che procurano pericolose forme di ignoranza. Sfiducia, presunzione, pregiudizio e indifferenza garantiscono a ciascuno solo la mediocrità della sopravvivenza. Invece tante volte, uscendo dalle proprie case e affilando negli occhi un’attenzione diversa, il viaggio comincia anche senza partire. Il turista diventa viaggiatore nella tensione costante verso chi non è, verso chi non gli rassomiglia e che non vorrebbe mai diventare. Quando non comprendiamo la diversità di chi ci vive accanto il mondo si chiude, e si fa amaro. Il rimedio è andare, fare, donare sempre e ovunque, operando la fede come lavoro gioioso, attento e disponibile: viaggio plurale, biglietto senza ritorno.