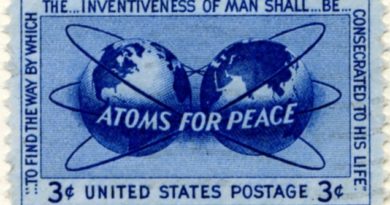Gigi Proietti con ‘libretto’ di Roberto Lerici. Un’opera sensibile al nulla più
L’equazione dimensionale della vita di Gigi Proietti ha avuto una scrittura emblematica e semplice da ricordare. Nato e scomparso nello stesso giorno e vissuto dal 1940 al 2020. L’anno dell’entrata in guerra dell’Italia e quello che sarà ricordato per l’esplosione di una pandemia. A proposito di questi due eventi storici, ho scelto di rievocare due momenti della vita artistica di Proietti che li rappresentano entrambi, quegli anni. Per ragioni diverse, in parte anche accomunabili, ma entrambe a registro di quella polarità intima e profonda che ha caratterizzato la poetica di un interprete bene al di là della leggerezza di molte delle altre cose che oggi vengono con affetto ricordate.
Due recitativi, tuttavia, ben noti a chi conosce bene gli spettacoli di Proietti e, in particolare, uno tra i più celebri. A me gli occhi, please, nato nella metà degli anni Settanta, e che in fasi differenti ha raccolto i due monologhi che sembrano i più giusti per rappresentare l’allegoria cronologica della parabola esistenziale di questo artista al quale diventa quasi inevitabile sentirsi affezionati.
Il primo è Mio padre è morto a diciotto anni, partigiano, scritto da Roberto Lerici. Un monologo, interpretato successivamente anche da altri attori, che racconta del dialogo tra un padre partigiano morto giovanissimo e suo figlio cresciuto, diventato adulto durante l’epoca di pace che, poco a poco, avrebbe poi dimenticato il sacrificio di quelle generazioni cadute sotto i colpi della seconda guerra mondiale, anzi, delle guerre, globalmente intese, che hanno caratterizzato la prima metà del “secolo breve”, a dispetto di quella rimozione di massa che, invece, avrebbe successivamente disonorato quei drammi e le loro vittime.
Nella conversazione tra padre e figlio, in una specie di sogno che allinea i due spazi temporali, Proietti sottolinea la distanza spirituale tra due generazioni che, sia pur l’una immediatamente successiva all’altra, si ritrovano a contemplarsi separate da un’alterazione della percezione delle cose della vita determinata da un progressivo quanto rapido mutamento dei tempi. Il generato non riconosce il generante, attribuendogli un significato bambino e fanciullesco paradossalmente alienato dalle preoccupazioni adulte di chi non sa, non immagina, non conosce il dolore di guerre che hanno cambiato l’umanità.
Allora, agli occhi del figlio la guerra del padre tramonta dietro il ricordo dolcissimo e lontano della prima giovinezza del genitore, simbolicamente ridotta alla sua immagine di calciatore. Eppure, in questo divario si annida la tragedia della semplicità di chi nella vita, da un momento all’altro, ha dovuto fare i conti con il senso più brutale e spietato della violazione, scaraventato dentro la norma dell’uomo contro l’uomo, condannato all’indisponibilità di quelle diplomazie che scongiurano la devastazione a cui invece la guerra ha sottoposto intere civiltà.
Successivamente, il padre partigiano confessa a suo figlio tutta la sua innocenza di uomo destinato alla mitraglia. Perché il Novecento è stato anche questo. Ha comandato agli uomini il nero paradosso per cui si può essere innocenti con un fucile tra le braccia e colpevoli da disarmati. E lo ha fatto riservando agli uomini la più ambigua e cinica filiazione. Quella che non unisce i padri e i figli, ma li separa in un tragico sistema di incomprensioni.
“Ma che ne so io de quello che è successo,
io so’ rimasto come v’ho lassato,
quanno giocavo, giocavo, giocavo…
giocavo a calcio e mica me stancavo,
giocavo co’ tu’ madre e l’abbracciavo,
giocavo co’ la vita e nun volevo,
coi nazisti io però nun ce giocavo…
io lottavo, lottavo, lottavo.”
Il 2020, invece, vorrei puntarlo in un omaggio a un altro monologo molto commovente di Gigi Proietti. Una poesia, anche questa, di Roberto Lerici, vagamente ispirata a un componimento di Jacques Prévert, che l’attore romano ha molte volte riproposto durante A me gli occhi, please e in altre occasioni in cui si è esibito a teatro o in televisione.
La poesia, intitolata Quest’amore, invoca il recupero di una nuova quanto antica capacità di innamorarsi. Un ritorno all’amore che non sia quello declinato troppo a lungo durante la post modernità, con le sue subdole e viziate contaminazioni, in un’alterazione corrotta e perversa del sentimento su cui si sono sempre interrogati artisti e intellettuali nel più beato e, al tempo stesso, tormentato degli smarrimenti, poiché nulla è certo e codificabile intorno alla parola amore, se non la sua potente fragilità e perpetua inafferrabilità.
L’amore cantato da Proietti è “un amore di fradicia letizia, che assolve tutto. Pure l’ingiustizia”. Una ricomposizione, quella di Lerici, che rievoca un concetto francescano della letizia, quella “Vera e perfetta letizia” che nelle Laudi e Preghiere delle Fonti Francescane definisce la vera virtù nella capacità di cedere anche se stessi e le proprie opere davanti alla loro richiesta di viversi indipendenti e affidate ai loro proseliti, pure da chi, come nel caso di Francesco d’Assisi, le ha fondate. La perfetta letizia è dunque il più alto senso di obbedienza e di libertà al tempo stesso, anche al di sopra del suo atto di fondazione.
L’amore denunciato da Quest’amore è un codice mistificatorio che ha radicato i peggiori egoismi, traducendoli in forme astute di glorificazione per mano alle più velenose strategie delle differenti forme di potere che se ne sono impossessati.
“quest’amore di cui si parla, tanto
celebrato con tutte le grancasse,
quest’amore è disceso tra le masse,
elargito per grazia del potere
perché tutti ne possano godere.
È un amore deforme, malandato,
generato dal vecchio capitale,
fra le cosce del mondo occidentale.”
I versi recitati da Proietti si concludono con l’invocazione a un tempo in grado di ritrovare l’entusiasmo amoroso privo d’altri scopi, se non quello di vivere disinteressatamente un sentimento che, già di per sé coniugato in molteplici piani spirituali e relazionali, nel caso della poesia di Lerici, si confessa ripiegato in se stesso, “Ha ripiegato pian piano le sue foglie, rinunciando per ora alle sue voglie”, nell’attesa che un giorno “Prima che il vuoto tutti ci divori, che venga, venga presto il tempo in cui ci si innamori”.
Tra un passato mai del tutto compreso e accettato, discusso troppe volte sotto il segno di un’inguaribile conflittualità, di frequente accompagnata da irriverenti e spiacevoli negazioni, il cui significato è rimasto spesso occluso invece che liberato nel suo indispensabile respiro e un presente che pare così lontano da quell’epoca che ha segnato col sangue dei lager le trasformazioni dell’uomo, si spera sopravviva la grazia dell’arte di quelli come Gigi Proietti. Il loro percorso, ammirato e duraturo, ha saputo segnare la risposta umile ed essenziale alla domanda ‘c’è ancora umanità in questo mondo?’.
I due monologhi scelti sembrano voler sfiorare quel passato e questo presente. Ironia della sorte, l’alfa/omega di un uomo che ha speso la sua vita in nome di una certa grazia dell’arte è coincisa con gli eventi che l’hanno caratterizzata. E in questo tempo così lungo, non poteva che allevarsi una sensibilità pari a quella di Gigi Proietti. Chissà cosa serbava dentro, fin nel profondo, senza che la sua apparente leggerezza ne desse conto o ne svelasse il benché minimo sospetto. Vicino al secolo, da un punto all’altro di due sponde che, se si guardassero da lontano, forse non si crederebbero. Gigi Proietti è stato tra quelli che hanno saputo durarsi senza scalfirsi. Non ci si fermi al luogo del suo sorriso, ma si prosegua pure verso quello che c’è dietro. Come per tutti quelli come lui. In arte, Gigi Proietti. In vita, il verbo genuino e spontaneo di sensibilità sull’orlo degli eventi.
Immagine di copertina da www.studentville.it