Nel nome di Domenico Rea: per il Centenario della nascita, intervista alla figlia Lucia
di Davide Speranza
Raccontare Domenico Rea significa fare un viaggio nel tempo e nello spazio. Affrancati, s’intende, da ogni stile e strada narrativa riconducibili a qualunque altro scrittore meridionale del Novecento. La sua Nofi, i personaggi e i luoghi, specchio e riflesso speculare di una Macondo alla Gabriel García Márquez, il realismo straripante nel ventre gonfio, crudo e maleodorante, eppure discolo e gioioso della Napoli che soffre, di quell’Agro Nocerino-Sarnese che pare una terra lontana, una Repubblica a parte: sono tutti elementi riconoscibili e unici, come pezzi rari di quadri rubati.
Rea è certamente uno dei più importanti narratori del secondo Novecento. Lo è anche contro le insabbiature di certa critica italica, che ha voluto relegarlo in un angolo. Ma Don Mimì non è stato dimenticato e il suo centenario (1921-2021) ha risvegliato gli animi, gettato nuova luce sulle storie di Nofi, ha generato l’ansia tarantolare della scoperta: cercare ogni anfratto immaginifico di Rea. Forse perché si è compreso che, in fondo, questo autore parla di noi, ancora di noi, non dei meridionali, ma degli uomini e delle donne, senza falsi trucchi e inganni, affrontando la realtà del sorriso e del pianto per quello che è, pur mai rinunciando allo studio antropologico e sociologico del perché il Sud sia così, del perché Napoli sia così. Da quest’ansia nasce il Centro Rea, il cui archivio – nella storica Villa Lanzara di Sarno – è stato voluto dalla figlia Lucia, con il coordinamento di Vincenzo Salerno (Professore di Letterature comparate e Storia della critica letteraria all’Università degli Studi di Salerno).
In queste settimane e nei prossimi mesi, molti saranno gli eventi a lui dedicati, tra Napoli, Nocera, Sarno: ripubblicazione di libri, concerti, mostre. Allora ci mettiamo in viaggio, alla ricerca di Lucia, depositaria della memoria più intima dello scrittore nocerino-napoletano. Oggi, pochi sanno che fu vincitore del Premio Strega nel 1993 con Ninfa Plebea: a confermare la necessità di togliere la polvere ammassata sulla figura di questo artista, è la notizia del “fuori catalogo” del romanzo. Fuor di polemica – e poi con chi? Con la cerchia dei critici di Stato? – per arrivare sulla soglia della dimora filiale, si sale il corpo slabbrato di Partenope. Si sale, fino a render dono agli occhi di una Napoli meravigliosa e decadente, borghese e sciatta, con i suoi tetti antichi, le case sgarrupate, la gente che ti accoglie e che se ne fotte, i monumenti santificati e il cono Vesuvio pater familias decisore di vita e morte. Lucia ci accoglie felice. I libri del padre, le dediche di autori internazionali, la luce del meriggio che sfuma ancora lentamente in questo concepimento di stagione autunnale. Nel saggio Le due Napoli, Rea scrive: «…abbiamo il dubbio che tra la Napoli cantata, narrata, rappresentata e voluta dai suoi medesimi abitanti e la vera, vi corra una notevole differenza… la Napoli vera è, sì, più violenta, ma più storica e meritevole di comprensione».
Ci sembra, ecco, che il gorgo intorno alla letteratura reana sia generato da questa contraddizione universale: verità e finzione, carne sudata e riscrittura fantasiosa. Rea non reinventa Napoli, la scrive, la decodifica, la traduce, grazie a una creatività diegetica sfrenata, mai staccandosi dalla superficie spigolosa dell’esistenza. Rea è figlio assoluto di Nocera – e molti lo hanno scordato – come è figlio assoluto di Napoli e di un Sud che vuol capire la giusta narrazione. Intanto, ci accomodiamo su una poltrona, spalle al pianoforte e alla biblioteca di famiglia. Con noi c’è anche la giovane Fiammetta, nipote di Mimì. Tra le mani mi vengono passati volumi, poesie, una foto in bianco e nero sul tavolino di vetro. Stiamo per entrare a Nofi. L’occhio di bue si placa su Lucia, inizia la storia di suo padre.
Non prima di avervi consigliato di leggerlo, Rea. Leggetevi Ninfa Plebea, Spaccanapoli, Gesù, fate luce, Quel che vide Cummeo, Fate bene alle anime del Purgatorio, Pensieri della notte, I ragazzi di Nofi. Ritroverete la vostra infanzia e adolescenza. Qualsiasi esse siano state, di qualsiasi epoca. Vivrete in quei personaggi la straziante frenesia di tanti Ulisse, in viaggio verso l’ignoto e il mistero dell’incontro con l’umanità.

Qual è il primo ricordo?
Una sera, lui era stato a un evento letterario, era tornato e mia madre preparava la cena. Se ne stava seduto in un angolo della cucina, mentre io mangiavo una cotoletta. Era stata cucinata una mini-cotoletta anche per la mia bambola. E io lo guardavo. Avevo 3 o 4 anni. Vivevamo a Posillipo. Ne ho tanti, di ricordi. Come il primo giorno di scuola, quando papà tornò festante con in braccio scatole di quaderni e colori. Ma quella cena con la cotoletta fritta è il primo frame di un film.
Cosa ha significato avere come padre Domenico Rea?
Lo sto scoprendo adesso, in profondità. Era un uomo pieno di sentimenti, valori importanti. E poi la sua empatia, il continuo credere nella lettura, anzi la certezza di fondare il valore della propria esistenza sulla lettura. Era un uomo molto amato, nonostante il suo carattere turbolento. Mi diceva sempre una frase: «Ti può capitare di perdere tutto nella vita, ma se conservi il piacere di leggere sarai una persona autonoma e ricca». La vitalità di questa persona era enorme. Grandi arrabbiature, grandi sofferenze esistenziali come tutti gli artisti. Ma anche momenti di allegria. Avevo soggezione di lui. Si è conservato i quaderni miei della prima elementare, i bigliettini che gli scrivevo. Mi voleva bene, ma la faccia che mi presentava era spesso brusca. La vita la godeva, la mangiava, l’afferrava. Diceva che un uomo intelligente, di sera, non cena mai da solo. Eppure aveva i suoi momenti di profonda solitudine. Insomma era un uomo complesso. Aveva due facce. Ricordo che scriveva di mattina. Scriveva articoli. Collaborava per Il Giorno, il Corriere della Sera, La Stampa, il Mattino, Repubblica, L’Europeo. Per moltissime riviste. Soprattutto per i quotidiani. Per vivere ha scritto sempre per i giornali, è entrato tardi alla Rai. Il resto della giornata lo dedicava alla lettura e alla correzione. Passava il tempo al telefono. Restava chiuso in questo studio e dietro quella porta sapevi che c’era una incandescenza che poteva sortire effetti negativi o positivi.
Quel periodo come ha inciso sulla vostra vita?
Quando frequentavo la Federico II, era la Napoli degli anni Settanta. Una città sessantottina. Molto intrisa di comunismo, di teatro sperimentale, di riunioni all’università, c’era ancora la “Saletta rossa” di Guida. Un fervore che si trascinava fin dai miei 13 anni, quando Jack Kerouac venne in città. Organizzarono Pellegrino Sarno e mio padre. A quegli incontri vennero anche Fernanda Pivano, Ginsberg, Quasimodo. L’evento con Kerouac si fece a Villa Pignatelli. Ero distratta, intimidita. Dentro di me rifuggivo da questi loro amici. Ma quello era un avvenimento importante e mi portarono. Una serata speciale con Jack completamente ubriaco. Il giorno dopo venne a casa nostra, con Domenico Porzio che allora lavorava alla Mondadori. Mi innamorai di quest’uomo dagli occhi di un blu strano, che solo gli americani possiedono. Mio padre parlava napoletano con Porzio, Jack parlava americano ed era ubriaco di birra. Insomma un pranzo sui generis. Mia madre fece questo ragù, i maccheroni diventavano freddi e Kerouac diceva che erano troppo buoni per mangiarli. Tra una portata e l’altra, ebbe anche l’ardire di chiederle un appuntamento. Lei rifiutò e lui le disse «sporca borghese». Mio padre non lo seppe mai. Alla fine Jack gli dedicò una poesia firmata. A casa venne a trovarci anche Allen Ginsberg. Suonava l’armonica nel nostro salotto. Ricordo molte persone quella sera. Spiavo dalla porta. E poi Montale, la Wertmüller. Insomma una infanzia e adolescenza costellate di personaggi leggendari, ma anche di persone semplici, come Gennarino il benzinaio. Anzi mio padre era molto più legato al popolo. La sua era una vita vicina alle persone semplici. Lo vedevano camminare tra i vicoli. Scriveva, lavorava, poi usciva e si premiava. Aveva alcuni sarti, si comprava le cravatte. Oppure se ne tornava con pacchi di vongole che faceva scivolare sul tavolo, e pacchi di dolci. Ricordo quando si sentì male. Era a Benevento a presentare un suo libro. Amava le taverne, le osterie. Tornato in camera fu colto da ictus, non riuscì ad arrivare al letto. Hanno dovuto rompere la porta per portarlo all’ospedale Rummo. Vaneggiava, ma parlava ancora di Parini, della sua scrivania, del suo blocchetto di note. Vedevo che quella potenza ed energia intellettuale si spegnevano. Quei momenti mi avvilirono. Tutto il percorso con mio padre mi ha in qualche modo cambiato l’esistenza. È stata una vita piena.
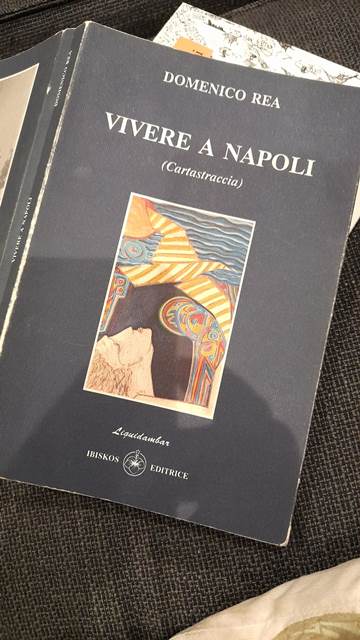
Sfatiamo un mito. Suo padre è nato a Nocera o a Napoli?
A Napoli, Quartiere San Ferdinando. Poi a 3 anni è andato a Nocera Inferiore. Una prima casa a via Garibaldi e poi dove si trova adesso il bar “Ideale”, la casa che conosco dove andavamo a trovare mio nonno. Ci siamo sempre andati a Nocera. Vi si recava per incontrare il padre, la sorella. Con suo padre non era mai andato d’accordo, ha adorato molto la madre. Però ha dedicato al padre un racconto nei Meridiani, la storia su come faceva il presepe. Un rapporto complicato. Il punto è che papà ha frequentato fino a quelle che all’epoca corrispondevano alle Medie, ma non c’erano soldi. Così è rimasto in mezzo alla strada per anni, ha preso il diploma magistrale da privatista, per il resto è stato un autodidatta. Francesco Durante raccontò bene come tutto ebbe inizio da una febbre. Costretto a letto, prese un libro della sorella, non ci capiva nulla, però lesse la storia, da lì cominciò l’amore per i vocabolari. Un suo amico gliene portò uno. Si appuntava i termini, i sinonimi. Era un ragazzo caratteriale, con una personalità umorale. I genitori lo portarono da Marco Levi Bianchini, direttore del manicomio di Nocera e amico di Freud. Il fatto che mio padre avesse cominciato a scrivere sempre sembrava una cosa strana ai suoi genitori. Bianchini capì subito che il suo destino era la scrittura. Così ha cominciato davvero. Si iscrisse a un concorso per giovani autori, gli dissero che aveva talento. Ma intanto lavorava nelle Cotoniere meridionali a Salerno, ha fatto il contrabbandiere di sigarette. È stato sempre un ragazzo con il problema di dover guadagnare. In un diario lessi che voleva avere la gloria e aiutare i suoi genitori. Poi, finalmente, ha iniziato a pubblicare articoli e a 25 anni ha partorito il primo libro: Spaccanapoli. È andato a Milano per un periodo. Fu subito un’esplosione di successo.
E Nocera? Cosa ha significato per lui?
Tanto. Lì sono nati i suoi personaggi, il suo immaginario. I rancori con la sua città, tanto promossi da alcune persone, non sono reali. Il mondo nocerino ha alimentato la sua narrativa. Mi parlava di Nocera in modo romantico. Raccontava dei viali alberati, dei profumi di gelsomino, delle passeggiate con le fidanzate, i caffè, gli ufficiali nei locali. Era innamorato della natura intorno a Nocera, Corbara, Sant’Egidio, Sarno, Cava de’ Tirreni. A Nocera ha conosciuto Giannino Stanzione, che vendeva giornali e prima ancora aveva la libreria; poi il regista Luciano Vecchi, Isaia Gabola, il confinato politico Luigi Grosso che lo ha messo in contatto con Milano. Come scordare la figura di padre Angelo Iovino. Papà prese a frequentare il convento di Santa Maria degli Angeli, i frati gli mettevano a disposizione la biblioteca. Padre Angelo lo ha avviato allo studio dei trecentisti. Tutto uno studio profondo portato avanti da sé. Di Nocera era innamorato.
Arriviamo a Napoli.
Ci si trasferisce dopo un anno di matrimonio. Aveva conosciuto mia madre a Nocera. Napoli, forse all’inizio, è stato un riscatto. Ne detestava qualsiasi forma di folclore. Non ha mai strizzato l’occhio a chi si compiaceva, come Di Giacomo, dell’immagine oleografica. Per mio padre, questa città era tutto il Sud. Era uno scrittore del Novecento e un meridionalista. Ha sempre avuto una forte empatia per Napoli. Pensava che avesse tanti difetti, che però andavano indagati. Vedeva le persone di questo paesone come Dio le fa nascere. Creature coperte solo dalla loro pelle. Persone che hanno subito molto dalla Storia. Napoli era l’unico mondo in cui poteva stare. Forse questo mondo, adesso, non lo riconoscerebbe molto. La globalizzazione ha investito anche questa città. Per intenderci, tra Eduardo e Viviani, mio padre preferiva il secondo che aveva uno sguardo più duro e reale. A questo proposito, Eduardo una volta venne a pranzo da noi. Papà, dopo averlo abbastanza combattuto in tempi addietro, era in soggezione dinanzi a lui. Eduardo era molto riservato, molto silenzioso. Si guardavano e si scrutavano come i bambini all’asilo. Poi scoppiò la discussione sul consumismo, la guerra, i vacanzieri, l’Italia che stava cambiando. Inoltre fu a Napoli che approfondì i suoi rapporti con Luigi Compagnone, Luigi Incoronato, Michele Prisco, Leone Pacini Savoj, Mario Pomilio. Fu tra i fondatori della rivista Le ragioni narrative, nello stesso periodo in cui iniziava a uscire l’avanguardia con Sanguineti. Con Compagnone si volevano bene. Prisco era diverso, era uno tranquillo. Peccato per l’incidente diplomatico con Anna Maria Ortese. Lei scrisse cose che, soprattutto dagli altri scrittori di Napoli, non furono ben accolte.
Ma con Pasolini com’è che andò davvero?
Mio padre lo ammirava. Scrisse un articolo calcistico su Pier Paolo. Si intitolava “Pasolini, una vita semplice”, un articolo uscito sul giornale Il Napoletano, prodotto per amanti del calcio, che vedeva Ferlaino editore. Era il 1975. Ma quell’articolo sembra introvabile ormai. Tempo prima, Pasolini lo contattò per sapere se avesse piacere di recitare nel film Uccellacci e uccellini, proprio nella parte che andò al grande Totò. Naturalmente mio padre non accettò.
Cosa si aspetta da questi 100 anni?
Sono felice dell’amore che gli stanno dimostrando. Credo sia stato trattato male, messo da parte dalla critica per troppo tempo. Ognuno si legge gli scrittori che vuole. La cosa importante è che gli sia riconosciuto quel che gli andava dato. Non è questione di vanagloria. Vorrei che tutto questo servisse per farlo conoscere ai giovani. Spero molto anche nel lavoro di digitalizzazione che faranno al “Centro Gatto-Rea” dell’università di Salerno. Per mio padre la lettura era un fondamento di vita. Mi aspetto questo dagli eventi del Centenario, che passi un messaggio ai giovani sull’importanza di leggere. E spero che i ragazzi lo conoscano, si avvicinino ai suoi libri e lo leggano.





