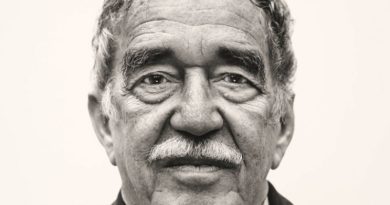L’atomica? “C’è una bomba N anche per le formiche”
Questo articolo nasce da un quesito che mi ha sottoposto un Lettore fortemente perplesso rispetto all’atteggiamento superficiale e sensazionalistico di una parte consistente dei media davanti alle commemorazioni dei settant’anni dell’atomica su Hiroshima e su Nagasaki.
Volutamente ho preferito pubblicare l’articolo dopo le date dello sgancio, 6 e 9 agosto, perché, al di là di ogni requiem protocollare e oltre ogni considerazione di ordine storico e politico, per Hiroshima e Nagasaki – parlo del loro valore simbolico – il silenzio non è andato via. Il fungo nucleare resta sospeso sul Giappone come al momento dell’esplosione del ’45. Il trauma giapponese non può essere rimosso. La sua testimonianza è trasversale e priva di ogni contaminazione conformistica. Dai dati scientifici ai riscontri letterari (la letteratura, mai dimenticarlo, è il riscontro per eccellenza dello stato psicologico di un popolo e di un clima politico), non si sfugge alla consapevolezza di un effetto definitivo nell’intimo giapponese. L’atomica è intervenuta sul pathos nipponico, alterandone le malinconie, le angosce, persino i rapporti con l’idea della morte, già di per sé diversamente intesa, per una cultura che crede a segni diversi rispetto a quelli occidentale. La narrativa, il teatro, il cinema, il fumetto, sono stati sottoposti a una rielaborazione psicologia che, come in nessun caso, rispondono a un trauma di terrore di massa paradossalmente consapevole, perché figlio di una sperimentazione diretta di quell’angoscia.
Le ragioni dell’uso della bomba nucleare da parte degli Stati Uniti d’America? Anche l’origine della tragedia nucleare si fonda su un ipotetico dato di immaturità del potere – o di lungimirante maturità – se si vanno a osservare alcuni documenti contemporanei ai giorni del lancio delle bombe, in particolare della seconda, a Nagasaki, quella che, secondo alcuni, non sarebbe dovuta nemmeno rientrare tra i piani di lancio sulla popolazione.
Stando alle fonti, “Fat Man” avrebbe dovuto colpire Kokura, un importante arsenale giapponese. Invece, a distanza di tre giorni dal bombardamento di Hiroshima, il secondo ordigno, forse a causa di imprevisti cambiamenti climatici, causò la morte di circa sessantamila persone, cadendo in un’area interamente occupata da civili. Secondo gli strateghi militari statunitensi, la bomba atomica avrebbe risparmiato tante vittime tra i militari americani e quelli giapponesi. Se non fossero caduti i due ordigni nucleari, gli Stati Uniti avrebbero invaso il Giappone, e questo, secondo i vertici politici e militari di allora, avrebbe avuto un costo molto alto, nonostante il Giappone fosse un paese ormai in ginocchio. Va ricordato che il concetto di resa, per i giapponesi, è molto diverso da quello “convenzionale”. In caso di invasione americana, decine di migliaia di soldati giapponesi si sarebbero fatti uccidere, pur di colpire il nemico e indebolirlo.
L’ordine di utilizzo e di lancio era stato dato da Truman poche settimane prima, dall’Europa, dove ormai la guerra era finita. Il presidente degli Stati Uniti si trovava a Postdam, vicino Berlino, quando il 25 luglio del 1945 decise di dare l’ordine di lancio sul Giappone. Lo stato, del tutto ipotetico, del sottile stadio di ingenuità che l’efferatezza del potere aveva raggiunto in quei giorni è testimoniato, in via parzialmente interpretativa, da quanto alcuni analisti hanno ipotizzato, rispetto a un passo del diario di Truman dove egli stesso ha scritto: “L’arma sarà usata contro il Giappone tra oggi e il dieci di agosto. Ho detto al segretario alla Guerra, Stimson, di usarla su un obiettivo militare, in maniera che il bersaglio siano soldati e marinai e non donne e bambini. Anche se i giapponesi sono selvaggi fanatici, senza scrupoli e senza pietà, noi in quanto leader del mondo libero non possiamo lanciare questa terribile bomba sulla vecchia capitale (Kyoto) o su quella nuova (Tokyo). Io e Stimson siamo d’accordo. Il bersaglio sarà puramente militare”. Invece il bersaglio, anzi, i bersagli, non furono militari.
Un elemento che potrebbe non essere casuale – sempre in uno schema di simboli – è che la decisione sia stata presa da Truman proprio in Europa, continente destinato a diventare colonia divisa tra l’impero statunitense e quello sovietico. Già la rivoluzione industriale e la prima guerra mondiale avevano pregiudicato l’impianto di secoli e secoli di storia. “I lampioni si stanno spegnendo su tutta l’Europa” aveva detto Edward Grey, ministro degli esteri della Gran Bretagna, guardando le luci di Withehall, mentre il suo paese entrava in guerra, nel 1914, contro la Germania, così come riportato da Hobsbawm ne Il secolo breve. Grey, a proposito di quelle luci, aggiunse “Nel corso della nostra vita non le vedremo più accese”. La seconda guerra mondiale ha poi provveduto a cancellarle definitivamente. Per certi versi, è come se il secondo conflitto mondiale avesse spazzato via l’ultimo umanesimo. E, forse, vinta dal suo stesso reflusso nordamericano che in cinque secoli aveva solcato l’Atlantico per ritornare redivivo invasore laddove era stato cacciato in panni galeotti, l’Europa è finita sotto i colpi di una spinta che nella bomba nucleare ha suggellato la fede assoluta nella forza delle armi. Il paradosso ha voluto che il “vecchio continente” collassasse per mano del “nuovo”, proprio attraverso una bomba lanciata lontano da tutti, in un paese estraneo ai legami storici e culturali dei due continenti e che, dopo la seconda guerra mondiale, avrebbe aderito con sorprendente ferocia allo sviluppo tecnologico.
I lampi dell’atomica, anche se avevano accecato soltanto gli occhi dei giapponesi e di chi aveva lanciato la bomba, hanno narcotizzato il mondo per sottoporlo a una metamorfosi che lo avrebbe cambiato per sempre. Soltanto gli incidenti avvenuti presso alcune centrali nucleari (Kyshtym, Three Mile Island, Cernobyl, Tokiamura e Fukushima, per citare i più gravi) avrebbero successivamente ridestato il timore verso l’atomica. Ma una cosa è la fatalità, altra è l’intenzione. In mezzo passa l’annientamento.
L’atteggiamento dei media votato a elaborazioni sensazionalistiche? Quello è forse l’aspetto più semplice da comprendere, in un’epoca, già attraversata da continue e spericolate incursioni edonistiche, nella quale domina il principio secondo cui, così come espresso dal filosofo Slavoj Zizek, “La politica poggia su un certo livello economico di godimento”. Non bisogna dimenticare che le nuove forme di comunicazione di massa hanno elaborato, grazie al processo di forte separazione tra centro e periferia, un impianto emotivo fondato proprio sui sensazionalismi e dentro le reazioni popolari. Uno tra gli effetti più terribili dei media è quello di aver suscitato emozioni spettacolarizzanti a ridosso dei fatti più gravi: la guerra, il terrorismo, la fame, per fare alcuni esempi. Dal punto di vista mediatico, per restare in tema, il sensazionalismo è la radiazione della presentazione e della descrizione di un fatto, con tutte le perversioni e le alterazioni che esse comportano.
La funzione sentimentale del sensazionalismo mediatico, che si inquadra nelle strategie della società di consumo, rientra nel confronto, antico e profondo, tra l’utilità e il significato della vita davanti a quello della morte. Dalla filosofia classica a quella moderna, dalla letteratura di Leopardi a quella di Camus, il grado polemico è vasto e consistente. In un saggio a cura di Chiara Lombardi, pubblicato sulla rivista Cahiers d’études italliennes, attraverso la citazione dell’Ecclesiaste e di un racconto di Alberto Moravia, C’è una bomba N anche per le formiche, contenuto nella raccolta La cosa, viene rievocata l’astuzia mediatica attorno al tema della distruzione di massa.
Moravia scrive:
“Alle sette del mattino, al mare, dopo avere spalancato la finestra, gli piace buttarsi tutto nudo sul letto, prendere il primo libro o rivista o giornale che gli capita sottomano e leggere per dieci, quindici minuti una cosa qualsiasi, per svegliarsi del tutto, per riprendere contatto con il mondo. Preferibilmente, qualche cosa di catastrofico, forse per equilibrare il senso di profonda tranquillità che emana dalla finestra piena di un cielo ancora freddo e vuoto, con vaghe tracce, qua e là, di rossori aurorali. Stamani tende la mano verso il pavimento, raccoglie a caso il giornale che la sera prima aveva lasciato cadere, vinto dal sonno, e lo spiega. Sì, ci vorrebbe qualche cosa di drammatico, magari di catastrofico. Ecco, su quattro colonne, il titolo che cercava, sul pro e il contro della bomba N. Benissimo, che cosa di più catastrofico della fine del mondo? Si accomodo meglio il cuscino sotto la testa, porta il giornale all’altezza degli occhi e legge.”
E il saggio citato giustamente osserva:
“C’è in questo scorcio la morbosa attenzione dell’uomo per la notizia catastrofica, come si dice diffusamente apocalittica, che la divulgazione di stampa e tv tende a sfruttare e ad esaltare in tutta la sua portata spettacolare. Il protagonista è però anche un uomo intelligente e capisce che sia l’attenzione per questi eventi sia la loro origine deriva dalla premessa che «l’umanità vuole morire». Ne è spinta dalla sua voglia di vivere, da quella stessa Wille che induce le formiche ad andare in cerca di miele, a spingersi «sul sentiero di guerra» e a farsi uccidere dall’insetticida (quello che è per loro la bomba N). L’osservazione della natura, la sua discreta, silenziosa presenza, è ancora una volta per Moravia un antidoto. La curiosità mediatica si fonde inevitabilmente, per il personaggio di questo breve racconto, all’osservazione del comportamento animale, al relativismo che ne deriva”.
E il racconto prosegue:
“Ne avrà ammazzate, diciamo, mille. Ma questa strage si è svolta nel silenzio, lui non ha sentito nulla. Eppure, chissà, forse le formiche si lamentavano, gridavano, urlavano. E ancora chi ha mai visto l’espressione della formica nel momento che muore colpita dall’insetticida? Agli uomini appare un puntino nero, niente di più?” E ancora, “L’ultima di queste cose nuove è la bomba N. Puoi forse dire, a proposito della bomba N, niente di nuovo sotto il sole? Eh no, proprio no. E allora, forse, delle cose di cui non si può parlare, è meglio tacere.”
Ecco, come bisbigliato dal fondo di grande sensibilità del suggerimento contenuto dal racconto di Moravia, “è meglio tacere”. Su Hiroshima e Nagasaki, piuttosto che interrogarsi su quanto e su come la forma celebri con puntualità e con incoscienza il requiem allo svanire, direi, invece che al morire, e se questo sia dovuto alle direzioni caotiche della storia o ad altro, resti soltanto la consapevolezza del privilegio di non essersi trovati lì.