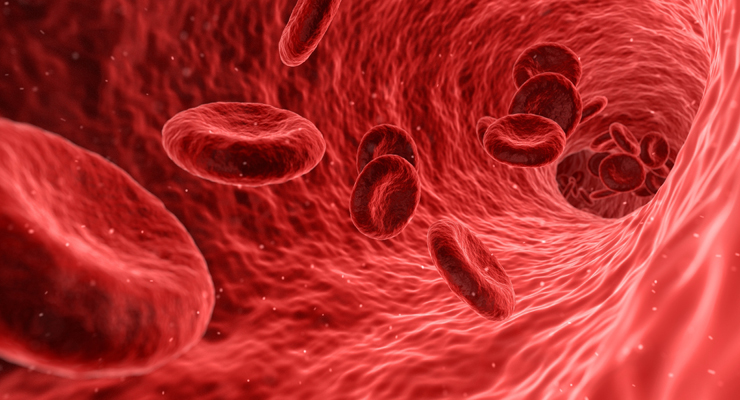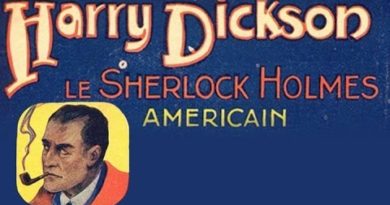Vampiri a Napoli – parte prima: Le vene di Partenope
Da quasi un secolo l’immagine fiabesca del paese del sole si discosta dall’utopia di Campanella celebrando la natura passionale, luminosa e diurna di Napoli, la città che per le sue caratteristiche meno si accorda con i vampiri, le creature del buio per eccellenza. Tuttavia, tra le incongruenze della metropoli possono convivere relazioni impensabili e, fra tutte, cercheremo di rintracciare i nessi che accostano la solare città di Bovio alla figura del non-morto, di norma associato da tradizione e letteratura ai nebbiosi scenari del settentrione.
Per trovare un capo del sinuoso filo rosso di collegamenti è necessario soffermarsi sul dualismo che marchia l’identità partenopea, scissa nella relazione col proprio territorio amato e vilipeso, nell’oscillazione della coscienza tra lucidità e oblio, nel vitalismo che scivola nell’inerzia più disperata. Questa frattura testimoniata liricamente da Raffaele La Capria o da Erri De Luca, si traduce in fatalismo o ferita mortale, spingendo alla resa o allo sradicamento mai risolutorio dell’esilio.
Per contrastare il peso esistenziale della precarietà e lo spauracchio di una disfatta incombente (di cui l’ombra del Vesuvio è un simbolico promemoria), i napoletani hanno opposto al fatalismo dell’antica matrice greca uno strumento di contrasto e difesa, lo scetticismo che nutre l’istintiva sfiducia verso ogni struttura sociale o di pensiero, liquidate come interpretazioni della realtà fallaci, o fraudolente, o peggio ancora illusorie.
Una filosofia analoga trova casa nell’esercizio dell’ironia, sempre demistificante e corrosivo, che parte dalla comicità popolare di Pulcinella passando per il teatro di Eduardo, gli anarchici sberleffi di Totò, e ancora i paradossi di Troisi, un comune sentire che sembrerebbe figlio di un razionalismo radicale, diffidente al punto da dubitare persino dell’affidabilità dei propri stessi sensi.
Eppure, in piena contraddizione a questo spirito iconoclasta, Napoli ha sempre coltivato e rispettato un vasto bagaglio di credenze in cui si ritrovano quotidianità e soprannaturale in una simbiosi impensabile che confonde insieme religione e superstizione, paganesimo e ortodossia.
Come non essere sorpresi dalla mole di rituali, devozioni e scongiuri che sono parte integrante della vita cittadina? Il moltiplicarsi delle tante Madonne, assimilazione cristiana delle arcaiche Matres Matutae, lo spettro della malasorte evocata da jatture e malocchio, la stretta relazione con l’Aldilà attraverso il culto dei morti sono alcuni degli esempi più eclatanti del doppio registro dei napoletani, identità nomadi che vivono in una continua messa in scena di se stessi, priva di una netta linea di confine tra oggettività e finzione.
In un contesto così ibrido, trova spazio ogni deroga al senso della “normalità”, facendo assumere alle varie simbologie del profondo una presenza fisica e concreta, rendendole parte integrante del vissuto di una moderna metropoli.
Il fiume carsico delle credenze scorre nelle vene dei luoghi devozionali, rendendo la città un bacino di liquidi sacri appartenenti a più piani di realtà, siano esse tangibili che ultraterrene. Ci riferiamo alla presenza delle molteplici reliquie che nel ‘600 hanno fatto meritare a Napoli l’appellativo di Urbs sanguinum, la città dei sangui.
Questo patrimonio ematico oggetto di venerazione secolare, è connesso nell’immaginario collettivo al miracolo di San Gennaro, ovvero lo scioglimento periodico del plasma custodito nelle ampolle esposte al pubblico nel corso di una secolare cerimonia che affolla il Duomo tre volte l’anno. Ma la definizione coniata dall’abate francese Jacques Bouchard si deve alla presenza di molti altri esempi, altrettanto misteriosi, altrettanto miracolosi, alloggiati in centinaia di sacrari che dotano la città di un metaforico apparato circolatorio, incessantemente in attività.
A fare da controparte del vescovo beneventano troviamo l’altra figura sacra che ne condivide il ruolo patronale, cioè Santa Patrizia, il cui lascito si liquefa nel monastero di San Gregorio Armeno ogni 25 di agosto, mese in cui avviene un analogo prodigio coi resti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (l’autore della cantata pastorale Quanno nascette ‘o ninno), e ancora quello dei santi Giovanni Battista e Lorenzo, preceduti il mese di giugno da San Pantaleone e da San Luigi Gonzaga nella Chiesa del Gesù Vecchio.
L’articolazione di questo itinerario ematico si dirama tra chiese e monasteri, comprendendo un impressionante numero di canonizzati e pie serve di Dio. Si annoverano trasmutazioni costanti come quelle di San Filippo Neri o Suor Maria Giuliana Arenare, il cui prodigio si perpetua da secoli, mentre altri miracoli hanno perso di regolarità, come quello del Protomartire Santo Stefano custodito nel celebre monastero angioino della Clarisse, altri ancora, invece hanno smesso definitivamente di manifestarsi, come nel caso dell’ampolla di San Giovanni Battista affidata alle monache di Donnaromita, ormai inerte dal 1600.
La straordinarietà dell’evento miracoloso, che l’illuminista Charles de Brosses reputava un mero artificio chimico, non è unico né nella sola Italia né nel resto d’ Europa – esemplari sono lo scioglimento del sangue di San Tommaso D’Aquino a Fossanova, o quello di San Pantaleone e Santo Stefano a Madrid e Besançon – eppure quel che rende particolarmente insolito il fenomeno nel capoluogo campano è la sua alta concentrazione sul territorio. Una ricchezza che ricercatori come padre Umberto Maria Fasola e padre Luigi Petito ritengono sia dovuta all’intenso traffico di profughi in fuga dalle persecuzioni religiose che hanno funestato il bacino del Mediterraneo. Una migrazione di uomini e culture che recava con sé tesori spirituali provenienti dai paesi di origine.
Napoli diventa così un approdo comune dei fuggitivi diretti in occidente, spesso custodi di quelle spoglie dei martiri destinate in seguito a fermarsi e diventare fondamento di chiese e monasteri.
Il macabro campionario dei veicoli di fede comprende i resti anatomici più assortiti, asportati in circostanze dai contorni incerti e oggetto di commerci dalla dubbia liceità. Tra essi, comunque, il sangue è l’unico a possedere una intrinseca valenza sacra, attribuzione risalente ai rituali votivi delle popolazioni barbariche. La venerazione degli antichi del “succo della vita”, considerato poi dai cerusici sede di purezza e “padre di tutti gli umori”, porta necessariamente alla sua assimilazione da parte della Cristianità, che ne addomestica le radici pagane, alle quali peraltro continua a restare tenacemente ancorata (come rimarca lo storico delle religioni Alfonso di Nola).
L’azione della reviviscenza funge da collante sociale della comunità, che si raccoglie quindi intorno all’evento il cui costante riprodursi rinnova la ciclicità della vita e la sua perpetuazione. Nel nostro caso, inoltre, è anche un diapason che accorda insieme i vincoli di affinità elettive tra la città irrorata dal sangue e gli esseri che, secondo le leggende, se ne cibano.
Per entrare nel merito dell’argomento vampirico rimandiamo alla tappa successiva del nostro fil rouge, passando dal piano antropologico a quello letterario, tra le pieghe di trattati settecenteschi e romanzi d’appendice dove si rivelerà sempre più la presenza napoletana di questo insospettabile, pallido turista.
Sarà forse per questo che, a ben guardare, tra i grappoli di pomodorini e le gabbiette di uccelli appesi ai balconi delle case più tradizionali un ciuffo di aglio non manca mai.